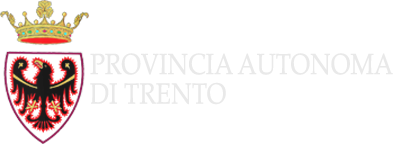Giovin signori. Gli apprendisti del gran mondo nel Settecento italiano
Il tema del variegato ceto nobiliare della nostra penisola da Nord a Sud al centro del libro di Alessandro Cont

Il libro di Alessandro Cont, Giovin signori. Gli apprendisti del gran mondo nel Settecento italiano, edito con la prefazione di Aurelio Musi nel 2017 (Roma, Società editrice Dante Alighieri) fa bella mostra di sé tra i volumi della Biblioteca della “Nuova Rivista Storica”.
Si tratta di una ricerca densa, erudita, ma di piacevolissima lettura condotta su 27 diversi archivi privati e pubblici, corredata di appendici documentarie e apparati iconografici inediti. Superando alcuni stereotipi derivati da fonti letterarie coeve quali il Giorno di Giuseppe Parini, l’autore affronta il tema del variegato ceto nobiliare della nostra penisola da Nord a Sud; l’arco cronologico prescelto che va dal 1701 al 1796 è funzionale a individuare continuità e trasformazioni di quel mos nobilium affermatosi fin dal secolo XVI all’ombra delle varie corti dei piccoli stati italiani.
In famiglia, a scuola, in società, il giovane nobile del Settecento italiano, dai 7 ai 35 anni, sperimenta l’allontanamento dalla casa paterna per istruirsi in qualche collegio della Compagnia di Gesù, per compiere un Grand Tour altrettanto formativo o per seguire, in alcuni casi, carriere militari o ecclesiastiche. Se talvolta entra in crisi il forte senso dell’onore alimentato da una scienza cavalleresca ormai implacabilmente derisa dal marchese Scipione Maffei, i “giovin signori” lombardi, toscani o siciliani hanno di che condividere: musica, ballo, teatro, conversazioni, accademie, servizio a gentili dame, ma anche questioni ereditarie e fedecommissarie che determinano rapporti più o meno idilliaci con genitori e fratelli.
Appartenere al “gran mondo”, per primogeniti e cadetti, è appartenere ad un’élite ben riconoscibile, non tanto sul piano delle origini e delle sfere di potere ormai dominate dall’assolutismo dei sovrani, quanto piuttosto sul piano dei riti della sociabilità che anima un’internazionale, ovvero quella del ceto nobiliare, nella Penisola come di là dalle Alpi.
Matrimoni contrastati, vocazioni e aspirazioni a diventare qualcosa di diverso da ciò che impongono le famiglie di origine sono le spie di un cambiamento in atto e, del resto, come non negare a ciascuno il suo posto nella vita?
Diversi talenti, diverse aspirazioni emergono dal bel documento che l’autore riporta a proposito dei sette fratelli Strozzi del ramo di Mantova descritti dal marchese Ludovico Andreasi: militare più o meno baldanzosamente in qualche esercito, o essere un buon capo di casa con moglie e numerosi figli, o decidere di vivere in una “filosofica tranquillità” fa parte di quel quadro variegato, curioso, intrigante, problematico che Alessandro Cont con perizia ha ricostruito come elemento costitutivo della società di Antico Regime.
01/02/2018